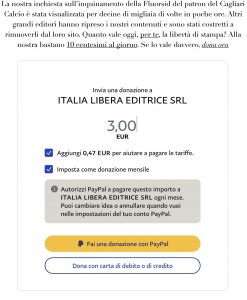La Fluorsid di Tommaso Giulini, patron del Cagliari Calcio, ha devastato l’aria, i terreni, le falde idriche e la laguna di Macchiaredu con tonnellate di rifiuti nocivi smaltiti abusivamente. Così racconta “Chemical Bros”, un documentario del regista Massimiliano Mazzotta, premiato al Festival Cinema Ambiente di Torino. L’inchiesta parte dal sogno, negli anni 60, del polo petrolchimico alle porte di Cagliari, diventato un incubo ambientale e sanitario; ci parla degli effetti della produzione dei composti fluorurati sulla salute di decine di migliaia di persone in Veneto. Secondo Medicina Democratica, da tempo in prima linea contro il leader mondiale nel ciclo del fluoro, anche la birra Ichnusa, prodotta ad Assemini, sarebbe contaminata. La risposta di Heineken, proprietario del marchio, alle nostre domande: «Possiamo fornire tutte le garanzie di sicurezza e qualità». Il sospetto dei dipendenti: «Ci usano per alzare il livello dello scontro tra ambientalisti e inquinatori»
L’inchiesta del nostro inviato MAURIZIO MENICUCCI, da Macchiareddu (Cagliari)
TEMPESTA IN UN BICCHIERE? In un certo senso è così, ma con qualche differenza, e non da poco. Prima di tutto, perché non parliamo di acqua, ma di birra, poi perché non vuol dire ‘tanto chiasso per nulla’. Al contrario, la vicenda è grave e, come non diceva Ennio Flaiano, anche seria. Comincia negli anni ’60, quando si pensò di trasformare l’isola dei nuraghe e della natura nel tempio della chimica industriale italiana; fu allora, ai tempi del ‘boom’, che società come la Sir, la Rumianca, l’Eni, la Saras dei Moratti e la Fluorsid dei Giulini presero a versare montagne di veleni, nel suolo, nel mare e negli stagni a Porto Torres, Ottana, Cagliari, e Portoscuso, tenendo per i soliti pochi il sogno di ricchezza e lasciando alla regione, allora la più industrializzata del Sud — oggi la più povera d’italia — l’incubo di centinaia di ettari devastati senza rimedio. Finisce (per ora) con la birra Ichnusa, prodotta dal gruppo olandese Heineken nello stabilimento di Assemini-Grogastu, vicino a Cagliari, coinvolta, probabilmente senza colpa, in uno dei più spiacevoli eventi che possano capitare a un’industria alimentare: alcuni campioni della più celebre delle ‘non filtrate e non pastorizzate’, che l’associazione Medicina Democratica ha fatto analizzare, risulterebbero contaminati dal fluoro. E, ovviamente, anche filtrarla servirebbe a ben poco, visto il tipo di sostanza.

La questione è delicata. Ci si muove in terra incognita, dove, tanto per dire, la legge non parla di limiti per il fluoro nella birra, eppure li prevede per l’acqua potabile, a eccezione della minerale. Ma le polemiche servono anche a risolvere problemi reali per troppo tempo ignorati, come la destinazione produttiva di territori saturi di rifiuti tossici. E, ad aumentare il sospetto della Ichnusa e del centinaio di suoi dipendenti d’essere il Cavallo di Troia di una pur sacrosanta guerra degli ambientalisti agli inquinatori, non tutti gli esperti concordano sulla reale pericolosità della contaminazione. Poche le analisi, obiettano, troppo diversi i risultati ed esigua, in ogni caso, la presenza del fluoro nella birra. Altri, invece, trovano la notizia tanto più allarmante in quanto indicherebbe che sono proprio le falde potabili più profonde e preziose del Cagliaritano, con cui si fabbrica la Ichnusa, a essere inquinate: una circostanza che gli enti pubblici di controllo, descritti da Medicina Democratica come «più che reticenti» sui dati delle analisi, oggi negano con decisione.

Però, un attimo di pazienza: per non saltare subito a conclusioni sommarie, dobbiamo riavvolgere il filo di questa storia e ripartire da un’altra, che a questa conduce, con molti risvolti, e non tutti noti. La racconta il documentario ‘Chemical Bros’ del regista Massimiliano Mazzotta, presentato fuori concorso nella sezione Made in Italy, pochi giorni fa, al 22° Festival Cinemambiente di Torino. Piccolo, ma importante retroscena: il festival italiano più importante del settore era senza dubbio la passerella ideale, per un’opera che denuncia, ma non rinuncia alla calligrafia, e per questo è stata premiata dalla giuria subalpina. Però, che quella sotto la Mole fosse un’anteprima assoluta è almeno insolito, perché l’intreccio è tutto sardo, e sardi quelli che vi han messo mano. Invece, a Cagliari, non si è riusciti, non solo a proiettarla, ma nemmeno ad accennarne per dire: ecco, è pronta, il tema è questo, fa discutere, e allora discutiamone. Giornali, tv, radio: niente di niente. Nemo propheta… si sa. Però, qualche ragione, stavolta ce l’ha anche la patria. Perché, se parli male di qualcuno, non puoi pretendere che quello ti regga il megafono. E a uscire piuttosto ‘sgualciti’ dal film di Mazzotta, alla sua terza prova nel genere, dopo le inchieste ‘Oil’ e ‘Oil, Secondo Tempo’ sui ‘benefici ecologici’ regalati all’isola dal polo petrolchimico dei Moratti, sono in tanti, tra imprenditori, amministratori locali ed enti tenuti a vigilare.

Il meno sgualcito della storia, invece, è proprio quello che in qualche modo ne è il deus ex machina, anzi ex fabrica: il magnate milanese Tommaso Giulini, figlio del conte Carlo Giulini, fondatore nel 1969 e proprietario di quella Fluorsid che fino al 2015 lavorava nell’agglomerato industriale di Macchiareddu — tra i comuni di Assemini, Capoterra e Uta — i minerali ricchi di fluoro dell’isola. Non proprio di fluoro, in verità, si tratta, ma dei suoi sali: la criolite, o esafluoroalluminato di sodio, e soprattutto la fluorite, o fluoruro di calcio. Il calcio, come si sa, ce l’abbiamo soprattutto nelle ossa. Giulini, però, deve averne un po’ di più, perché la sua seconda creatura, quella per cui è più noto, è proprio il Cagliari Football Club. Acquisita nel 2014, la squadra gli ha dato tante soddisfazioni, almeno fino all’anno scorso. L’ultima stagione è andata male: serie B, tifosi che lo contestano, lui che parla di vendere: il Cagliari, naturalmente, perché di mettere sul mercato la Fluorsid, non ha mai fatto cenno. E non si può dargli torto. La vera macchina da goal è lo stabilimento di Macchiareddu, che i locali chiamano ‘il capannone dello zio Tom’. E un motivo ci sarà.
Prima di proseguire, però, un’avvertenza. Così come magnate non deriva dal romanesco ‘magnare’, nel nome Macchiareddu, che in ‘sa limba’, la lingua sarda, sta, più o meno, per macchiolina, non c’è alcun presentimento di future pesti ecologiche. Ricorda solo che una volta, in questa zona lagunare, ora compresa nei 57 Sin e Sir italiani (vuol dire Siti d’Interesse Nazionale, o Regionale, i più inquinati della Penisola), c’era solo la macchia mediterranea. Poi, nel 1953, si scoprì che il suolo di Silius, a cinquanta chilometri da Cagliari, celava una delle migliori vene al mondo di fluorite e, nel 1969, i Giulini ne avviarono il ciclo: estrazione a Silius, lavaggio ad Assemini, raffinazione e accumulo a Macchiareddu, vicino agli imbarchi, e poi, via, a influorare il mondo.

Nel 2009, la miniera di Silius ha chiuso. Tutti a casa, nonostante la Regione Sardegna, nuovo socio unico di Giulini, vi avesse versato 25 milioni a fondo perduto (anche di vista), e nonostante le stime che potesse rendere per altri vent’anni: guarda caso, proprio quanti sono stati i minatori italiani e polacchi morti per crolli e altri brutali incidenti, negli anni in cui si scavava. La Fluorsid, invece, ha continuato a macinare profitti, lavorando fino al 2017 il materiale importato dalla Gran Bretagna, dove possiede un’altra miniera a Cavendish Hill, nel Derbyshire. Inglese, tra l’altro, sarebbe anche il nome ‘fluorite’ dato in origine ai suoi cristalli, ambiti dai collezionisti per il colore cangiante e fluorescenti al buio.
Il suo primo valore, tuttavia, consiste nella universale utilità. Con i suoi fluoroderivati inorganici, entra in decine di produzioni industriali, contribuendo al fatto che più di un sardo su tre, (seicentomila persone!) vive in un sito contaminato, primato nazionale con relativi eccessi di malattie e morti; serve alla fusione delle ceramiche, del vetro e dei metalli come l’alluminio, altra storia disgraziata che ha lasciato al sud Sardegna la maxidiscarica dieci metri fuoriterra di Portovesme-Portoscuso, con ottantamila metri cubi di fanghi rossi; è indispensabile per trasformare il petrolio in carburante, attività cui è legata l’ingombrante presenza della Saras, la raffineria dei Moratti, nel vicino comune di Sarroch, dove quattro passi tra le case spiegano bene perché certi composti organici si chiamano aromatici; si usa, come esafluoruro, per arricchire l’uranio, della cui parte impoverita, quella che appesantisce le munizioni per fondere i blindati, si possono trovare i souvenir velenosi, sotto forma di nanopolveri cancerogene, nei terreni e nei fondali dei poligoni militari di Quirra, di Teulada e in tutti i più recenti teatri di guerra, compreso, a tonnellate, quello ucraino.

Anche da sola, comunque, la fluorite è pessima per la salute e l’ambiente. Non è un caso che Mazzotta dedichi il suo film al regista Stanley Kubrick, facendolo partire proprio dalla sequenza, del ‘Dr. Stranamore’ in cui un generale psicopatico confessa a Peter Sellers di bere solo alcool puro perché «i comunisti sovietici vogliono avvelenare l’America con l’acqua fluorata». Dietro il paradosso, c’è molta verità. Per la tossicologia, la polvere di fluorite, in particolare il fluorosilicato, non dissimile, in questo effetto, dall’amianto, intacca i polmoni e favorisce il cancro. Inoltre, altera a vari livelli il metabolismo, soprattutto, ma non solo, perché libera anche acido fluoridrico, uno dei più corrosivi e reattivi in assoluto, che è anche il principale prodotto della Fluorsid.
Fa male, insomma, ma non si può generalizzare. A Giulini, ad esempio, ha fatto molto bene. Grazie alla fluorite sarda e inglese, è riuscito ad allargare il suo gruppo a mezzo mondo, fondando un vero impero sulla catena del fluoro. Possiede società in Svizzera, Germania, Norvegia, Inghilterra, Svizzera. Dal 2018 al 2021, attraverso la Alkeemia, ha avuto anche la proprietà della Solvay di Porto Marghera. La stessa società belga è indicata dagli esperti come una delle principali fonti, insieme alla Miteni (cioè, Mitsubishi più Eni) dei famigerati Pfas e Pfoa, composti perfluoroalchilici studiati allo scopo di resistere all’acqua e ai solventi, ad esempio, nelle pentole antiaderenti, nei cartoni delle pizze, nei tessuti come il Goretex, nelle schiume antiincendio. Per la stessa ragione, si ritrovano intatti nelle acque e nei suoli di buona parte della Pianura Padana, nonché negli alimenti e nelle cellule di molti suoi abitanti. A farne le spese, in particolare, una sessantina di comuni tra Vicenza, Verona e Padova, dove, dopo il lungo inquinamento causato dalla Miteni di Trissino, fallita nel 2018, l’allattamento materno è a rischio, e l’incidenza di tumori, difficoltà neurocognitive, diabete, infertilità e mancata crescita conferma l’estrema capacità di questi derivati del fluoro di interferire con gli ormoni.
Già, la catena alimentare. Quando entrano in circolo, i derivati del fluoro fanno molti danni, anche alle pecore che brucano nei prati attorno alla fabbrica di Giulini e alle discariche abusive disseminate in un ampia fetta del sud Sardegna. Questo però ve lo racconteremo domani. (1 – continua) © RIPRODUZIONE RISERVATA