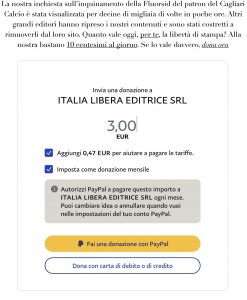Animali morti con denti e ossa deformati, produzioni agricole e pesca azzerate, dovunque polveri capaci di corrodere perfino l’alluminio dei guard rail. Poi, nel 2017, le indagini dei forestali sardi, l’inchiesta della Procura di Cagliari, e i manager che, arrestati per disastro ambientale, tre anni fa patteggiano uno sconto di pena. I funzionari dell’Arpas che avevano ‘dimenticato” di cercare il fluoro? Non imputabili, perché la legge non lo imponeva. E il capo azienda Giulini? Non poteva sapere che le concentrazioni di alluminio fossero pari a 3475 volte il limite di legge, e dei fluoruri pari a 1154 volte, perché impegnato con il Cagliari Football Club. Ma come procede il piano di bonifica che impegnava la Fluorsid davanti ai giudici? L’azienda non risponde alle nostre domande e, secondo i forestali, si concentra sulla discarica di Terrasili, ma il problema sono i terreni intorno, dove erano state tombate grandi quantità di scorie. E alcuni test sulla birra Ichnusa, fabbricata lì accanto, indicherebbero concentrazioni troppo elevate di fluoro
L’inchiesta del nostro inviato MAURIZIO MENICUCCI, da Macchiareddu (Cagliari)
QUANDO LE PECORE allevate a Macchiareddu, dapprima una, così risultava ufficialmente, poi ben 1200, hanno cominciato ad accusare i sintomi e anche a morire di fluorosi, malattia che deforma le ossa e le rende fragili come vetro — ovviamente non solo agli ovini, ma anche agli umani — i pastori si sono messi a far baccano. E con loro, i pescatori, i mitilicoltori e gli agricoltori, i cui prodotti venivano accolti con crescente diffidenza dal mercato, anche se qualcuno, come Francesco Carboni, che sostiene d’aver perso 600 agnelli di stenti e strane malattie, spesso con denti così grandi da non riuscire più a brucare, al mercato nemmeno ci arrivava. Tutti ad accusare quella polvere bianca luccicante e impalpabile, che il vento disperdeva da decenni su decine di ettari intorno. Ma, come si capirà poi, quella era solo una piccola parte delle morchie che la Fluorsid, dopo aver finto di ripulirle, smaltiva abusivamente all’esterno della discarica di Terrasili, nel Comune di Assemini, ormai satura e fuori controllo, come gli stessi manager dell’azienda e del suo indotto si raccontavano l’un l’altro nelle intercettazioni telefoniche.

Nel 2017, dopo tre anni di indagini della Forestale Sarda, il Pm Marco Cocco apre l’inchiesta, indagando sedici persone — sette subito agli arresti — tra dirigenti di secondo livello della Fluorsid, responsabili di una società esterna, e tre funzionari dell’Arpas, poi usciti dal processo. Pesanti le accuse: associazione a delinquere in inquinamento e disastro ambientale. In parole povere, avere avvelenato almeno una quarantina di ettari tra Macchiareddu e Monastir di terreni, falde idriche e fondali lagunari, gettandovi fanghi acidi, fluorosilicati, amianto e altre sostanze non depurate, e smaltendo materiali e mezzi industriali inquinati con sotterfugi e carte false. Per la Procura, un piano architettato «al preciso scopo di tagliare i costi e massimizzare i profitti».
Impressionanti le concentrazioni di alluminio, pari a 3475 volte il limite di legge, e di fluoruri, pari a 1154 volte, in un campione di falda superficiale di Terrasili, dove, secondo un operaio, intervistato nel film documentario “Chemical Bros”, si versavano fluorosilicati a colpi di diecimila litri per volta. Onnipresente, nelle palte delle tre discariche abusive individuate, le più allarmanti in un mare di ettari contaminati, il tricloroetilene, o trielina, solvente cancerogeno. E per chi, dei dipendenti, si azzardava a raccogliere foto e video degli illeciti, il trattamento era quello, lacrime e sangue, promesso da Michele Lavanga, ex direttore Fluorsid, le cui raffinate parole risuonano nel documentario di Mazzotta: «Se questa roba va in giro, io vi inc…».

Vistosa e prolungata, la ‘trance’ dei controlli pubblici, tanto più che, scrive il Gip, Cristina Ornano, «il primo produttore al mondo di derivati del fluoro era già stato condannato, seppur civilmente, per problemi legati ai danni ambientali». Conferma oggi uno dei forestali incaricati di indagare: «Mentre il territorio si saturava di rifiuti chimici, l’Istituto Zooprofilattico, l’Arpa Sardegna e Asl facevano il minimo richiesto dalla legge». Ai funzionari indagati, paradossalmente, il fluoro servì da cavillo di battaglia per scansare il processo: contaminante poco comune, non è tra le sostanze che si devono ricercare di routine, dunque l’omissione non è un reato. «Il che è vero — premette il forestale —; la norma, però, dice anche di regolarsi in base al contesto industriale: quando so che lì si producono composti del fluoro, è il buon senso a suggerirmi di verificare se ci sono i loro residui nell’ambiente».
Nel 2019, tra una condanna, certa come le prove dello scempio e oltretutto con la gogna del pubblico dibattimento, e un’assoluzione probabile come il cammello nella cruna, gli undici rimasti alla sbarra scelsero il danno minore: patteggiamento, in cambio di ventitré mesi di carcere. «Che non è un’ammissione di colpa», ammonì il prestigioso collegio dei difensori, riuscendo a non ridere grazie alle laute parcelle. A suggellare l’accordo con la giustizia, l’impegno del mecenate Giulini a investire 27 milioni di euro in una bonifica che, a detta dei suoi legali «era stata programmata prima che l’inchiesta entrasse nel vivo».

Una delle doti che distinguono i grandi imprenditori è la tempestività. L’altra è l’immunità: il capo non sa mai quel che fanno i dipendenti infedeli. In realtà, il nome di Giulini, indagato nei primi atti, era stato eliminato dal fascicolo grazie al fatto che, diventato presidente del Cagliari, aveva delegato ogni decisione della holding ai dirigenti. «Azienda e società non sono coinvolte nella sentenza di patteggiamento», aveva precisato, a caldo, Guido Manca Bitti, avvocato della Fluorsid.
Che la fine della vicende giudiziarie non segni la fine di quelle ambientali lo dicono le cronache, lo conferma la scienza. Oltretutto, accanto alla Fluorsid hanno lavorato per più di mezzo secolo, scaricando anche di peggio, molte altre industrie chimiche, come 3M, Enichem, Eni-Sindyal e la solita raffineria Saras, in queste settimane di nuovo sotto l’attenzione della Procura per reati ambientali. In uno ‘scenario inquinato’ così vasto e complesso, dove ogni azienda ha lasciato la propria firma chimica indelebile, una bonifica radicale comporterebbe costi enormi e problemi tecnici insolubili. In questi casi, ci si limita a mitigare la diffusione dei veleni nel sottosuolo con muri affondati fino al primo strato di roccia impermeabile e pompe che intercettino le falde contaminate per riportarle continuamente nella massa: queste sono, appunto, le opere che si stanno realizzando nella discarica di Terrasili a Macchiareddu, ora in via di dissequestro, sebbene gli agenti Forestali lascino intendere che la tipizzazione, l’individuazione delle sostanze presenti, sia stata piuttosto sommaria.

Quanto allo stabilimento Fluorsid, in attesa dell’Aia, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, l’attività starebbe per riprendere, nel segno, così dichiara il suo sito, della più fulgida sostenibilità. Il territorio devastato dai rilasci della discarica debordante e malgestita e dalle pratiche criminali dalla vecchia linea di comando del gruppo, però, è molto più vasto. E se chiedi, sempre ai forestali, che cosa si stia facendo per controllarlo, ti rispondono come Roy Batty nella scena finale di Blade Runner: “Abbiamo visto cose che voi umani..”. È un fatto che, dopo l’inchiesta, sui terreni circostanti Terrasili e nelle acque della laguna di Santa Gilla, molti hanno ripreso, se mai avessero smesso, a lavorare e a produrre come prima: pescatori e molluschicoltori, serre di frutta e ortaggi, animali al pascolo, il cui latte è destinato anche a noti caseifici regionali e di gruppi nazionali, stando a quanto dichiarano due pastori nel documentario di Massimiliano Mazzotta. Le ordinanze comunali che lo vietavano non sono state fatte rispettare. «Il Comune non ha gli strumenti, abbiamo chiesto un incontro all’assessorato, ma non ci hanno risposto» si schermisce, nel documentario, Sabrina Licheri, da poco ex sindaca 5Stelle di Assemini.
Ovviamente, anche la Ichnusa non ha mai smesso di imbottigliare la sua birra fatta con acqua prelevata da pozzi locali alla profondità di 84 metri, come ci dichiara la Heineken. Che il fluoro della pur vicina Fluorsid arrivi laggiù parrebbe improbabile. Eppure, racconta “Chemical Bros”, nel 2019, un cittadino di Cagliari, comprata una bottiglia di Ichnusa e, segnati data e lotto, l’aveva consegnata, dichiarandola ‘fatta in casa’, a un laboratorio cagliaritano. Risultato dell’analisi: 4.8 mg al litro di fluoruri, tre volte il valore limite, che per le bevande è di 1.5. Pensando a una contaminazione accidentale, il mese dopo, aveva fatto ripetere l’analisi a un altro laboratorio sardo. Risultato: 27.7 milligrammi al litro, quasi venti volte il limite. Allora era ritornato con un terzo campione al primo laboratorio, e stavolta i milligrammi erano 3.5 al litro, più del doppio del limite.
E la Regione Sardegna, in tutto questo pandemonio, c’è o è evaporata? e se c’è che fa? Qui la questione diventa fin troppo seria. Ve la raccontiamo domani, assieme alle valutazioni dell’Ichnusa nell’ultima parte, per ora, della nostra inchiesta. (2 – continua; la prima parte è stata pubblicata ieri) © RIPRODUZIONE RISERVATA