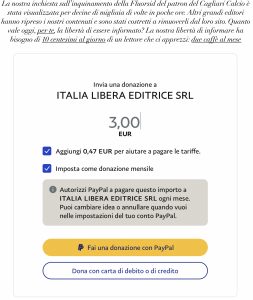Perché passano gli autunni, o altre stagioni, e queste ribellioni non si vedono? La risposta è semplice se si guarda ai più miseri, precari di ogni tipo, rider per le consegne e così via: non hanno massa critica e un’organizzazione sociale che possa rappresentarli. I sindacati ufficiali hanno da tempo abdicato a ogni ruolo sulle nuove esigenze e figure sociali, limitandosi a cercare di difendere, non sempre con successo, il lavoro che c’è. Ed è vero che siamo gravati da un rapporto deficit/Pil del 150%, ma vanno citati altri dati fondamentali: il risparmio complessivo degli italiani, il loro patrimonio edilizio e l’attivo della bilancia commerciale. Riguardo al primo, era stimato in 16.000 miliardi di euro in tempi pre-Covid e non è certo diminuito col record del 2020. Una cifra, questa, superiore al Pil tedesco 2021. E quindi, mandiamo a casa il “banchiere”! Nelle chiacchiere da bar o nelle invettive pubbliche, può sempre funzionare. Qui da noi
L’articolo di MASSIMO SCALIA
“L’INSOSTENIBILE SITUAZIONE che Draghi ha lasciato al Paese non potrà non sfociare in un pesante malessere sociale e in dure manifestazioni popolari!” Ancora, la “vera” sinistra ripropone, senza vergogna, il ritornello dell’autunno caldo. L’ultimo c’è stato se mal non ricordo nel 1969. Poi, grande resistenza contro le trame nere e piduiste, militanza e grandi manifestazioni contro il terrorismo brigatista o per la difesa dei valori democratici. Grandi e nobili battaglie, necessarie battaglie, ma, tutte, per usare un linguaggio antico, “sovrastrutturali”, politiche. Come le stesse battaglie ambientaliste, che rivendicano e in parte ottengono obiettivi concreti, ma si svolgono anch’esse su un terreno eminentemente cultural-politico. Per fortuna, sui grandi temi globali del futuro, della loro drammatica urgenza. Nessun autunno caldo “sociale”, allora, tranne mobilitazioni che potranno anche non essere pacifiche di tassinari, balneari e di qualche altra grossa corporazione. Alle quali già pensa da tempo e con successo la Meloni.

Ma perché questo scetticismo su incisive mobilitazioni non corporative? Già oltre quarant’anni fa un pensatore non banale, Nikos Poulantzas, lamentava come le ribellioni più significative avessero luogo “a monte o a valle della classe operaia”. E potremmo metterci dentro, a surrogare la perdita di peso fisico e politico della classe operaia, anche i ceti medi in sofferenza e tutti i detentori di un giusto titolo per ribellarsi. Perché passano gli autunni, o altre stagioni, e queste ribellioni non si vedono? O meglio, una me la ricordo, quando centomila lucani per due settimane “occuparono” la loro costa ionica contro il decreto “Scanzano”. Una ribellione civilissima, neanche un cassonetto bruciato, e vincente contro la pretesa del governo Berlusconi di fissare con decreto-legge il deposito delle scorie radioattive. Ebbe una risonanza europea e storica, su un tema importante ma che non poteva essere generale.
E allora, tornando all’interrogativo, la risposta è semplice se si guarda ai più miseri, precari di ogni tipo, rider per le consegne e così via: non hanno massa critica e, soprattutto, un’organizzazione sociale che possa rappresentarli. I sindacati ufficiali hanno da tempo abdicato a ogni ruolo sulle nuove esigenze e figure sociali, limitandosi a cercare di difendere, non sempre con successo, il lavoro che c’è.

Ma c’è una corposa massa di italiani, milioni e milioni, che, pur avendo titolo a ribellarsi, non lo fanno. Perché? Una risposta non particolarmente originale, “strutturale” si sarebbe detto una volta, è che la realtà socioeconomica del Paese non è come ama rappresentarsela la maggioranza dei nostri concittadini. Né come quelle indagini sociologiche che, un po’ paraculescamente, assecondano il vezzo. Del resto, come non assecondare quando è standard l’icona dell’opulenta signora, di uno degli innumerevoli paesotti, che si accanisce a spiegarti che oggi “si sta peggio”? Dimentica del fatto che, molti anni prima, quando “si stava meglio”, su quella piazzetta allora sterrata le donne con gonnelloni a terra piangevano l’assenza, vera, di servizi e trasporti, qualcuna lasciando alla fine una chiazza perché era meglio “farla” lì, sulla polvere, nascosta dal gonnellone, che non nel cessetto sul balcone, dove l’acqua corrente era un desiderio.

Ora, è vero che siamo gravati da un rapporto deficit/Pil del 150%, ma, a proposito di “ricchezza nazionale”, vanno citati dei dati fondamentali spesso negletti: il risparmio complessivo degli italiani, il loro patrimonio edilizio e l’attivo della bilancia commerciale. Riguardo al primo, era stimato in 16.000 miliardi di euro in tempi pre-Covid e non è certo diminuito col record del 2020. Anche se è difficile pensare che possa continuare a crescere, ammonisce il Censis, che ci informa pure che solo un quarto di quel patrimonio costituisce la “ricchezza finanziaria” [leggi qui nota 1]. Una cifra, questa, superiore al Pil tedesco 2021, che conferma gli italiani come risparmiatori irriducibili ma assai affezionati al contante e poco propensi a investire in titoli di Stato, come accade invece in Paesi nostri competitori. Il Giappone ha un deficit/Pil decisamente superiore a quello italiano, 257%, ma i bravi giapponesi investono massicciamente in titoli di Stato, per cui sono di fatto i creditori di buona parte di quel debito, al contrario degli italiani che, patrioti veri, non vogliono arricchirsi con lo spread.
Gli italiani sono anche recordmen, e women, del titolo di ‘possessore di almeno un’abitazione’, con oltre l’80%. Una percentuale che scende al disotto del 50% in molti Paesi europei, dove sono state però realizzate adeguate politiche sociali per la casa. Alla resa dei conti, mazziati ma non cornuti, se si guarda alla sorte individuale, con circa 200 milioni di vani [leggi qui nota 2], oltre tre volte la popolazione. Con buona pace di Trilussa e della statistica sui polli mangiati.

Le esportazioni italiane hanno toccato nel 2021 il record di 516 miliardi di euro e un saldo positivo dell’interscambio commerciale di oltre 53 miliardi di euro; positivo, come in tutti gli anni a partire dal 2012 e con una quota di mercato superiore a quella della Francia. Certo, questo andamento potrà essere messo in crisi dal caro energia del 2022, ma resta il fatto che dal 2017 l’Italia detiene il secondo posto in Europa, dopo la Germania, nel settore manifatturiero.
Un ricordo lo meriterebbe anche quel “tesoro” rappresentato della “Cassa Depositi & Prestiti”, che nel suo piano industriale 2019-2021, ben prima dell’attivazione del Recovery Fund, aveva in programma di mobilitare oltre 200 miliardi di euro di investimenti a favore di imprese, infrastrutture e territorio: 110 miliardi di risorse proprie della CDP, destinati alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile del Paese; altri 90 miliardi di risorse aggiuntive, previste da investitori privati e altre istituzioni territoriali, nazionali e sovranazionali.
Questi fondamentali sfatano alcune immaginette di comodo a uso degli italiani, piagnoni ma furbi, riproposte da indagini compiacenti verso un certo “sentire comune”. Un autunno caldo? Ce ne sarebbe ben donde, per l’aspetto richiamato in apertura [leggi qui anche l’articolo di ieri], ma sarebbe iniquo richiederlo a oppressi e/o non organizzati. E, poi, le ribellioni, lamentava Poulantzas già oltre 40 anni fa… E quindi, mandiamo a casa il “banchiere”! Nelle chiacchiere da bar o nelle invettive pubbliche, può sempre funzionare. Qui da noi. (2- fine; la prima parte è stata pubblicata ieri) © RIPRODUZIONE RISERVATA