Il diritto di parola è garantito per tutti: competenti o incompetenti, informati o disinformati, in buona fede o in pessima fede, appassionati di qualcosa o orecchianti “della qualunque”. E la lista dei sinonimi e contrari potrebbe allungarsi quasi all’infinito. La questione è, però, piuttosto seria: fin dove è consentito negare l’evidenza, se hai ruoli di una qualche responsabilità pubblica? Una vecchia regola giornalistica − soffocata nel vociare ininterrotto e indistinto dei social, cui si accodano per sopravvivenza non pochi organi di informazione grandi e piccoli − recita: i fatti prima delle opinioni. Volendo si può invertire anche l’ordine ma il risultato non cambia: le sciocchezze restano tali e i fatti hanno la testa dura… Tanto più a distanza di anni
◆ L’articolo di GIANFRANCO AMENDOLA

► Opinione n. 1: «Quando vai sull’Adamello e sul Tonale e vedi i ghiacciai che si ritirano anno dopo anno ti fermi a pensare, poi studi la storia e vedi che sono cicli… Dire che sei per la transizione energetica e sei contro l’energia nucleare è un controsenso. Il nucleare è l’energia più pulita, stabile e sicura, abbiamo 432 centrali nucleari operative nel mondo che non producono scorie. Siccome non sempre c’è vento o sole, c’è bisogno anche di tutte le tre fonti di produzione energetica. …Chi dice no al nucleare dice no al futuro, ne sono assolutamente convinto».
Opinione n. 2: «Esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. È vero che ci sono altri fattori (quali il vulcanismo, le variazioni dell’orbita e dell’asse terrestre, il ciclo solare), ma numerosi studi scientifici indicano che la maggior parte del riscaldamento globale degli ultimi decenni è dovuta alla grande concentrazione di gas serra (biossido di carbonio, metano, ossido di azoto ed altri) emessi soprattutto a causa dell’attività umana. La loro concentrazione nell’atmosfera ostacola la dispersione del calore che la luce del sole produce sulla superficie della terra. Ciò viene potenziato specialmente dal modello di sviluppo basato sull’uso intensivo di combustibili fossili, che sta al centro del sistema energetico mondiale. Ha inciso anche l’aumento della pratica del cambiamento d’uso del suolo, principalmente la deforestazione per finalità agricola…».
 La prima opinione è quella del ministro Salvini, la seconda quella di papa Francesco (Enciclica “Laudato si”) il quale già nel 2015 aveva esattamente capito quali tempi ci aspettavano, stigmatizzando che «cresce un’ecologia superficiale o apparente che consolida un certo intorpidimento e una spensierata irresponsabilità che ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. È il modo in cui l’essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi autodistruttivi: cercando di non vederli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni importanti, facendo come se nulla fosse»; aggiungendo che anche fra i credenti «gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche». Parole profetiche in un mondo dove ogni giorno aumentano gli inviti alla cautela ed al ripensamento di “talebane” misure di contenimento non sopportabili dalle nostre economie. E non si tratta solo di Salvini: una recente indagine di Greenpeace evidenzia, infatti, che solo nell’8% delle dichiarazioni dei principali leader politici italiani si fa almeno un accenno alla crisi climatica, ma quelle realmente dedicate al riscaldamento del pianeta sono appena il 4%, e includono anche le dichiarazioni contrarie alle azioni per il clima.
La prima opinione è quella del ministro Salvini, la seconda quella di papa Francesco (Enciclica “Laudato si”) il quale già nel 2015 aveva esattamente capito quali tempi ci aspettavano, stigmatizzando che «cresce un’ecologia superficiale o apparente che consolida un certo intorpidimento e una spensierata irresponsabilità che ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. È il modo in cui l’essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi autodistruttivi: cercando di non vederli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni importanti, facendo come se nulla fosse»; aggiungendo che anche fra i credenti «gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche». Parole profetiche in un mondo dove ogni giorno aumentano gli inviti alla cautela ed al ripensamento di “talebane” misure di contenimento non sopportabili dalle nostre economie. E non si tratta solo di Salvini: una recente indagine di Greenpeace evidenzia, infatti, che solo nell’8% delle dichiarazioni dei principali leader politici italiani si fa almeno un accenno alla crisi climatica, ma quelle realmente dedicate al riscaldamento del pianeta sono appena il 4%, e includono anche le dichiarazioni contrarie alle azioni per il clima.
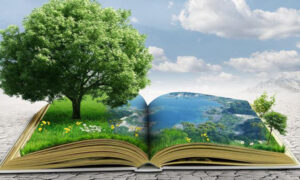 Le vere ragioni di questa situazione ce le spiega ancora una volta papa Francesco: «Una strategia di cambiamento reale esige di ripensare la totalità dei processi, poiché non basta inserire considerazioni ecologiche superficiali mentre non si mette in discussione la logica soggiacente alla cultura attuale. Una politica sana dovrebbe essere capace di assumere questa sfida. …La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pongano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana». Ed è proprio su queste considerazioni che sette anni dopo, nel 2022, è stato aggiunto, nella nostra Costituzione, che «la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni» (art. 9) e che l’iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41), collegando la tutela dell’ambiente agli altri valori fondamentali dell’individuo.
Le vere ragioni di questa situazione ce le spiega ancora una volta papa Francesco: «Una strategia di cambiamento reale esige di ripensare la totalità dei processi, poiché non basta inserire considerazioni ecologiche superficiali mentre non si mette in discussione la logica soggiacente alla cultura attuale. Una politica sana dovrebbe essere capace di assumere questa sfida. …La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pongano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana». Ed è proprio su queste considerazioni che sette anni dopo, nel 2022, è stato aggiunto, nella nostra Costituzione, che «la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni» (art. 9) e che l’iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41), collegando la tutela dell’ambiente agli altri valori fondamentali dell’individuo.
 Insomma, come ancora una volta preconizzava papa Francesco, «semplicemente si tratta di ridefinire il progresso. Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso…ma occorre una profonda trasformazione politica, che abbandoni i dogmi della crescita, del mercato e del Pil…. È realistico aspettarsi che chi è ossessionato dalla massimizzazione dei profitti si fermi a pensare agli effetti ambientali che lascerà alle prossime generazioni? All’interno dello schema della rendita …non si considerano seriamente il valore reale delle cose, il loro significato per le persone e le culture, gli interessi e le necessità dei poveri». Il progresso, cioè, è cosa ben diversa dalla crescita e «dobbiamo convincerci che rallentare un determinato ritmo di produzione e di consumo può dare luogo ad un’altra modalità di progresso e di sviluppo». Occorre, quindi, liberarsi al più presto della «ossessione per uno stile di vita consumistico», e «per questo è arrivata l’ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti. …La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. Si può aver bisogno di poco e vivere molto, soprattutto quando si è capaci di dare spazio ad altri piaceri».
Insomma, come ancora una volta preconizzava papa Francesco, «semplicemente si tratta di ridefinire il progresso. Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso…ma occorre una profonda trasformazione politica, che abbandoni i dogmi della crescita, del mercato e del Pil…. È realistico aspettarsi che chi è ossessionato dalla massimizzazione dei profitti si fermi a pensare agli effetti ambientali che lascerà alle prossime generazioni? All’interno dello schema della rendita …non si considerano seriamente il valore reale delle cose, il loro significato per le persone e le culture, gli interessi e le necessità dei poveri». Il progresso, cioè, è cosa ben diversa dalla crescita e «dobbiamo convincerci che rallentare un determinato ritmo di produzione e di consumo può dare luogo ad un’altra modalità di progresso e di sviluppo». Occorre, quindi, liberarsi al più presto della «ossessione per uno stile di vita consumistico», e «per questo è arrivata l’ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti. …La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. Si può aver bisogno di poco e vivere molto, soprattutto quando si è capaci di dare spazio ad altri piaceri».
 Riflessioni di Papa Francesco in piena sintonia, peraltro, con quanto, molti anni prima aveva sostenuto Enrico Berlinguer (Discorso al Convegno degli intellettuali del 1977) parlando della «austerità» e spiegando che «l’austerità non è oggi un mero strumento di politica economica cui si debba ricorrere per superare una difficoltà temporanea, congiunturale, per poter consentire la ripresa e il ripristino dei vecchi meccanismi economici e sociali. Questo è il modo con cui l’austerità viene concepita e presentata dai gruppi dominanti e dalle forze politiche conservatrici. Ma non è così per noi. Per noi l’austerità è il mezzo per contrastare alle radici e porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi strutturale e di fondo, non congiunturale, di quel sistema i cui caratteri distintivi sono lo spreco e lo sperpero, l’esaltazione di particolarismi e dell’individualismo più sfrenati, del consumismo più dissennato. L’austerità significa rigore, efficienza, serietà, e significa giustizia; cioè il contrario di tutto ciò che abbiamo conosciuto e pagato finora, e che ci ha portato alla crisi gravissima i cui guasti si accumulano da anni e che oggi sì manifesta in Italia in tutta la sua drammatica portata».
Riflessioni di Papa Francesco in piena sintonia, peraltro, con quanto, molti anni prima aveva sostenuto Enrico Berlinguer (Discorso al Convegno degli intellettuali del 1977) parlando della «austerità» e spiegando che «l’austerità non è oggi un mero strumento di politica economica cui si debba ricorrere per superare una difficoltà temporanea, congiunturale, per poter consentire la ripresa e il ripristino dei vecchi meccanismi economici e sociali. Questo è il modo con cui l’austerità viene concepita e presentata dai gruppi dominanti e dalle forze politiche conservatrici. Ma non è così per noi. Per noi l’austerità è il mezzo per contrastare alle radici e porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi strutturale e di fondo, non congiunturale, di quel sistema i cui caratteri distintivi sono lo spreco e lo sperpero, l’esaltazione di particolarismi e dell’individualismo più sfrenati, del consumismo più dissennato. L’austerità significa rigore, efficienza, serietà, e significa giustizia; cioè il contrario di tutto ciò che abbiamo conosciuto e pagato finora, e che ci ha portato alla crisi gravissima i cui guasti si accumulano da anni e che oggi sì manifesta in Italia in tutta la sua drammatica portata».
 Guasti che, ormai, sono ben visibili non solo in Italia ma in tutto il mondo, anche se termini come “decrescita” e “austerità” ci fanno istintivamente storcere il naso. Forse è giunto il momento di parlare anche della “felicità” di vivere in un mondo più sano e più equo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Guasti che, ormai, sono ben visibili non solo in Italia ma in tutto il mondo, anche se termini come “decrescita” e “austerità” ci fanno istintivamente storcere il naso. Forse è giunto il momento di parlare anche della “felicità” di vivere in un mondo più sano e più equo. © RIPRODUZIONE RISERVATA


